In questa sezione della biblioteca virtuale pubblichiamo una serie di pubblicazioni aventi per oggetto la ricerca speleologica in tutti i suoi canpi con particolare riguardo all’idrografia delle grotte, gli studi idrogeologici, geologici, e le ricerche archeologiche svote sul Carso Triestino ed in altre aree d’Italia.
Brecce pleistoceniche sul Carso
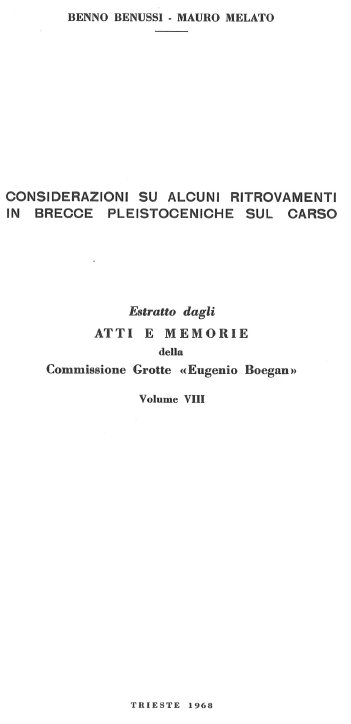 Gli autori tracciano un saggio di cronologia, assoluta e relativa, dei riempimenti di cavità del Carso di Trieste, per quanto riguarda le associazioni di faune quaternarie contenute; fra cui ossa fossili di pachidermi, attribuibili all’interglaciale Riss-Wurm o alla fase finale dell’anaglaciale wiirmiano. Alcuni recenti ritrovamenti di ossa fossili di mammiferi pleistocenici — in brecce ossifere del nostro Carso, di genesi, origine ed età non sempre concordanti — hanno riproposto il tema della datazione, assoluta e relativa, dei riempimenti di cavità che le racchiudono.
Gli autori tracciano un saggio di cronologia, assoluta e relativa, dei riempimenti di cavità del Carso di Trieste, per quanto riguarda le associazioni di faune quaternarie contenute; fra cui ossa fossili di pachidermi, attribuibili all’interglaciale Riss-Wurm o alla fase finale dell’anaglaciale wiirmiano. Alcuni recenti ritrovamenti di ossa fossili di mammiferi pleistocenici — in brecce ossifere del nostro Carso, di genesi, origine ed età non sempre concordanti — hanno riproposto il tema della datazione, assoluta e relativa, dei riempimenti di cavità che le racchiudono.
Estratto Atti e Memorie Volume VIII
Breccia ossifera di Visogliano
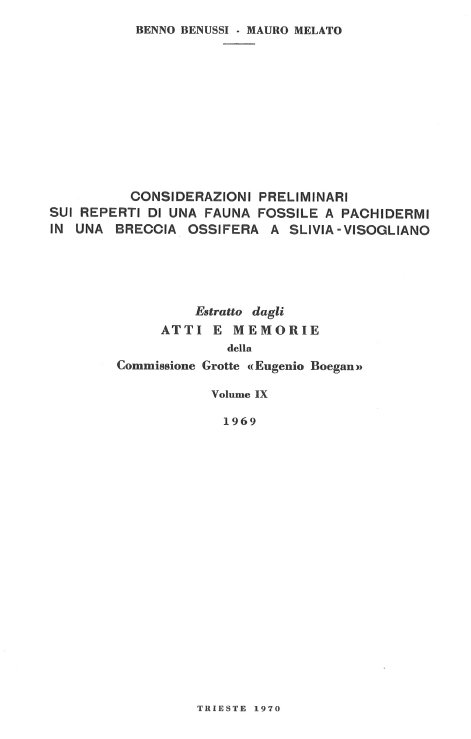 Gli autori — premesse le precedenti considerazioni sui ritrovamenti di fossili nelle brecce ossifere del Carso — descrivono più particolarmente alcuni caratteri rilevati sulle serie dentarie ivi rinvenute, attribuibili all’H. Amphibius ed al Rh. Merckii, sottolineando le analogie con altri reparti in Italia e in Europa.Nella breve relazione, comparsa su «ATTI E MEMORIE» nel settembre 1969, ci eravamo proposti di enunciare — in una sommaria sintesi — alcune considerazioni preliminari sui recenti ritrovamenti di ossa fossili di pachidermi nelle brecce ossifere della zona di Bristie e Slivia.
Gli autori — premesse le precedenti considerazioni sui ritrovamenti di fossili nelle brecce ossifere del Carso — descrivono più particolarmente alcuni caratteri rilevati sulle serie dentarie ivi rinvenute, attribuibili all’H. Amphibius ed al Rh. Merckii, sottolineando le analogie con altri reparti in Italia e in Europa.Nella breve relazione, comparsa su «ATTI E MEMORIE» nel settembre 1969, ci eravamo proposti di enunciare — in una sommaria sintesi — alcune considerazioni preliminari sui recenti ritrovamenti di ossa fossili di pachidermi nelle brecce ossifere della zona di Bristie e Slivia.
Estratto Atti e memorie Volume IX
Formazione delle grotte per cattura di corsi d’acqua
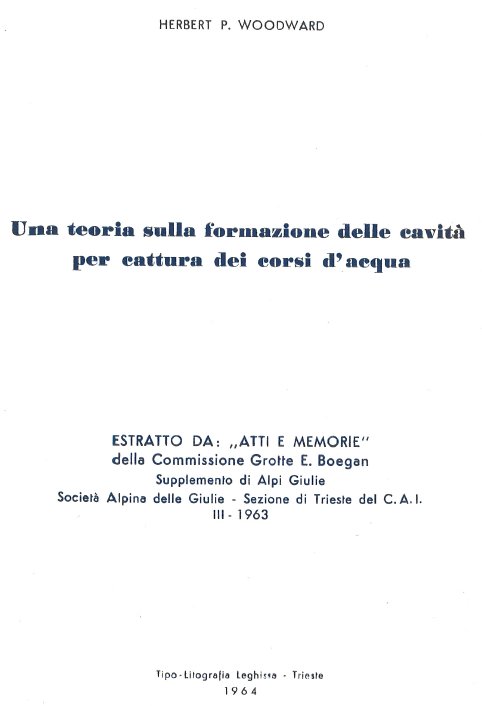 Dopo un primo sommario esame, soprattutto per l’originalità e la novità delle idee espresse, spesso in palese contrasto con le ipotesi speleogenetiche noi riteniamo che la zona studiata dall’Autore presenti delle caratteristiche ben diverse dagli olocarsi, forse più frequenti e certamente più studiati in Italia, e spesso, ed a torto, presi quale unico, od almeno più tipico esempio di carsismo. Accanto alle zone profondamente incarsite con netta prevalenza di cavità verticali o subverticali, esistono zone in cui la galleria è la regola ed il pozzo l’eccezione, spesso dovuta a fenomeni secondari e successivi che mettono in comunicazione gallerie e caverne formatesi a differenti livelli in epoche successive. Ci sembra quindi utile presentare ai colleghi italiani questo studio, affinchè possa colmare qualche lacuna nel campo delle ricerche speleogenetiche
Dopo un primo sommario esame, soprattutto per l’originalità e la novità delle idee espresse, spesso in palese contrasto con le ipotesi speleogenetiche noi riteniamo che la zona studiata dall’Autore presenti delle caratteristiche ben diverse dagli olocarsi, forse più frequenti e certamente più studiati in Italia, e spesso, ed a torto, presi quale unico, od almeno più tipico esempio di carsismo. Accanto alle zone profondamente incarsite con netta prevalenza di cavità verticali o subverticali, esistono zone in cui la galleria è la regola ed il pozzo l’eccezione, spesso dovuta a fenomeni secondari e successivi che mettono in comunicazione gallerie e caverne formatesi a differenti livelli in epoche successive. Ci sembra quindi utile presentare ai colleghi italiani questo studio, affinchè possa colmare qualche lacuna nel campo delle ricerche speleogenetiche
Estratto Atti e memorie Volume III
Formazione riempimento e sviluppo delle grotte
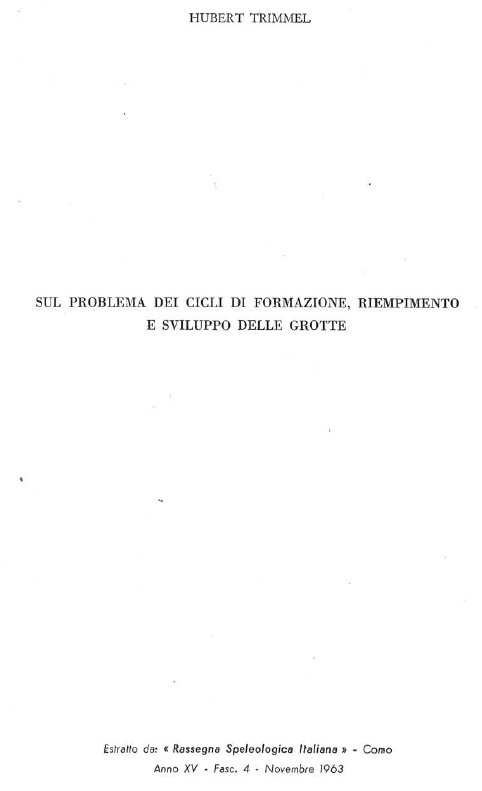 Questo studio è stato presentato in tedesco dall’Autore al Symposium Internazionale di Speleologia {Varenna, ottobre i960). Esso mi è parso ricco di idee interessanti ed originali, per cui l’ho tradotto in italiano per uso mio e di alcuni miei amici. Successivamente ho pensato che valesse la pena di pubblicarlo sulla Rassegna Speleologica Italiana affinchè un maggior numero di speleologi italiani potessero venire a conoscenza dei concetti di questo studioso straniero.
Questo studio è stato presentato in tedesco dall’Autore al Symposium Internazionale di Speleologia {Varenna, ottobre i960). Esso mi è parso ricco di idee interessanti ed originali, per cui l’ho tradotto in italiano per uso mio e di alcuni miei amici. Successivamente ho pensato che valesse la pena di pubblicarlo sulla Rassegna Speleologica Italiana affinchè un maggior numero di speleologi italiani potessero venire a conoscenza dei concetti di questo studioso straniero.
Ringrazio il prof. Trimmel che ha gentilmente acconsentito alla pubblicazione della versione italiana del suo lavoro, il dott. Antonio Alberti che mi ha aiutato nella traduzione ed il prof. Walter Maucci che l’ha riveduta.
Rassegna speleologica Italiana Anno XV
Reticolo idrografico sull’Altipiano dell’Alburno
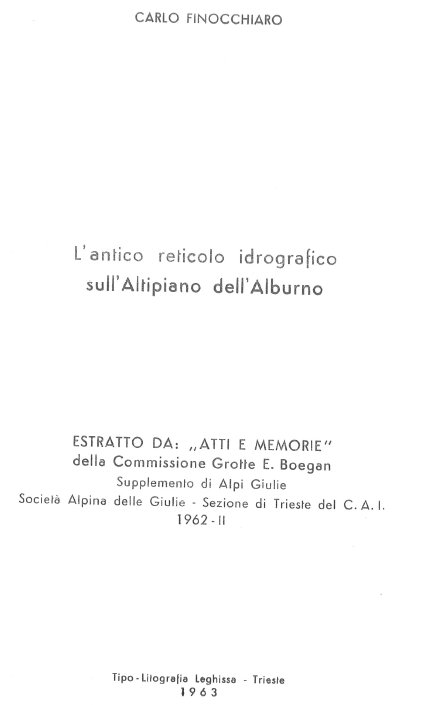 Cessata l’azione delle forze endogene che danno la primitiva struttura tettonica alle terre emerse, le superfici calcaree sono modellate dalle stesse forze esogene che modificano la morfologia delle aree impermeabili: le acque di precipitazione atmosferica in primo luogo, ritenendo agenti generalmente: secondari il vento, l’alternanza del caldo e del freddo, i ghiacciai. Ci sembra che per la conoscenza del fenomeno carsico dì una determinata regione sia opportuna la ricostruzione dell’eventuale sistema idrografico superficiale, così come si ritiene necessaria la conoscenza della geologia e della tettonica della zona da studiarvi, cioè di tutti quei fattori che hanno condizionato le forme carsiche superficiali e sotterranee, e per i quali appunto le forme carsiche, pur presentando caratteristiche simili, si distinguono da area ad area.
Cessata l’azione delle forze endogene che danno la primitiva struttura tettonica alle terre emerse, le superfici calcaree sono modellate dalle stesse forze esogene che modificano la morfologia delle aree impermeabili: le acque di precipitazione atmosferica in primo luogo, ritenendo agenti generalmente: secondari il vento, l’alternanza del caldo e del freddo, i ghiacciai. Ci sembra che per la conoscenza del fenomeno carsico dì una determinata regione sia opportuna la ricostruzione dell’eventuale sistema idrografico superficiale, così come si ritiene necessaria la conoscenza della geologia e della tettonica della zona da studiarvi, cioè di tutti quei fattori che hanno condizionato le forme carsiche superficiali e sotterranee, e per i quali appunto le forme carsiche, pur presentando caratteristiche simili, si distinguono da area ad area.
Estratto da Atti e Memorie volume II
Le acqua sotterranee dell’altipiano di San Servolo
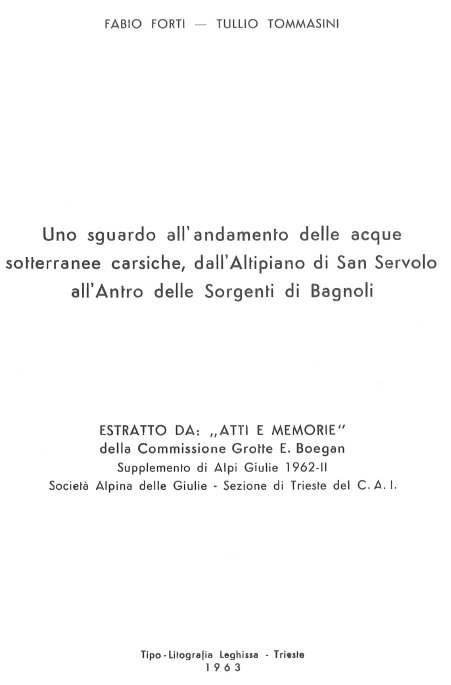 Fra i problemi geologici più appassionanti, anche nei riguardi pratici, che presentano le rocce carsiche, emergono le questioni connesse con la circolazione sotterranea delle acque. Questioni vecchie, si potrà dire; questioni vecchie, si, ma mai superate. Abbiamo voluto riprendere questa frase per giustificare il presente lavoro.
Fra i problemi geologici più appassionanti, anche nei riguardi pratici, che presentano le rocce carsiche, emergono le questioni connesse con la circolazione sotterranea delle acque. Questioni vecchie, si potrà dire; questioni vecchie, si, ma mai superate. Abbiamo voluto riprendere questa frase per giustificare il presente lavoro.
scarica la ricerca in formato pdf
Ricerche carsiche anni 1985-1995
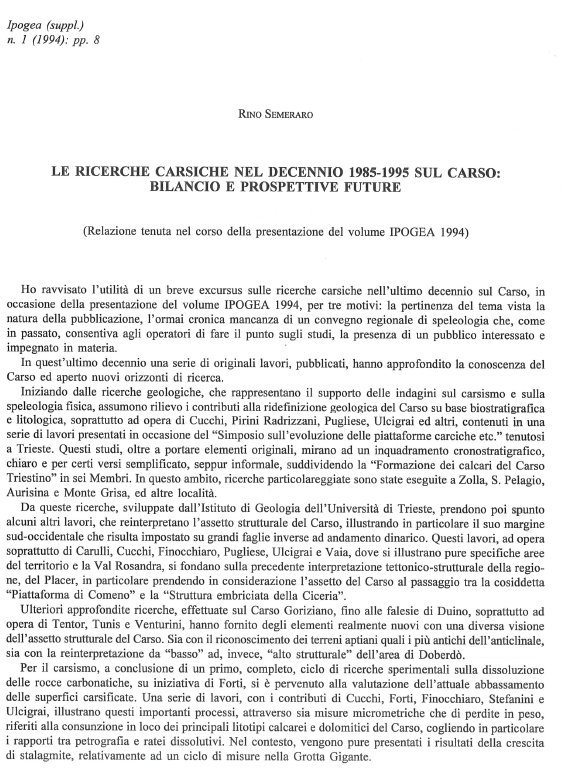 Ho ravvisato l’utilità di un breve excursus sulle ricerche carsiche nell’ultimo decennio sul Carso, in occasione della presentazione del volume IPOGEA 1994, per tre motivi: la pertinenza del tema vista la natura della pubblicazione, l’ormai cronica mancanza di un convegno regionale di speleologia che, come in passato, consentiva agli operatori di fare il punto sugli studi, la presenza di un pubblico interessato e impegnato in materia.
Ho ravvisato l’utilità di un breve excursus sulle ricerche carsiche nell’ultimo decennio sul Carso, in occasione della presentazione del volume IPOGEA 1994, per tre motivi: la pertinenza del tema vista la natura della pubblicazione, l’ormai cronica mancanza di un convegno regionale di speleologia che, come in passato, consentiva agli operatori di fare il punto sugli studi, la presenza di un pubblico interessato e impegnato in materia.
In quest’ultimo decennio una serie di originali lavori, pubblicati, hanno approfondito la conoscenza del Carso ed aperto nuovi orizzonti di ricerca.
Analisi di concrezioni stalgmitiche
 Nell’ambito delle ricerche sull’evoluzione tettonica recente del Friuli-Venezia Giulia e di quelle sulle deviazioni dalla verticalità degli assi delle stalagmiti svolte rispettivamente da ricercatori degli Istituti di Mineralogia e di Geologia e Paleontologia dell’Università di Trieste e dell’Istituto di Geologia e Paleontologia dell’Università di Bologna afferenti al Progetto Finalizzato Geodinamica- Sottoprogetto Neotettonica è stato eseguito uno studio statistico della disomogeneità di accrescimento degli assi delle stalagmiti della Grotta Gigante corredato dall’analisi statistico-strutturale dell’area del Carso Triestino in cui la grotta si apre.
Nell’ambito delle ricerche sull’evoluzione tettonica recente del Friuli-Venezia Giulia e di quelle sulle deviazioni dalla verticalità degli assi delle stalagmiti svolte rispettivamente da ricercatori degli Istituti di Mineralogia e di Geologia e Paleontologia dell’Università di Trieste e dell’Istituto di Geologia e Paleontologia dell’Università di Bologna afferenti al Progetto Finalizzato Geodinamica- Sottoprogetto Neotettonica è stato eseguito uno studio statistico della disomogeneità di accrescimento degli assi delle stalagmiti della Grotta Gigante corredato dall’analisi statistico-strutturale dell’area del Carso Triestino in cui la grotta si apre.
Atti 5° Convegno speleologico FVG
I miriapodi cavernicoli italiani
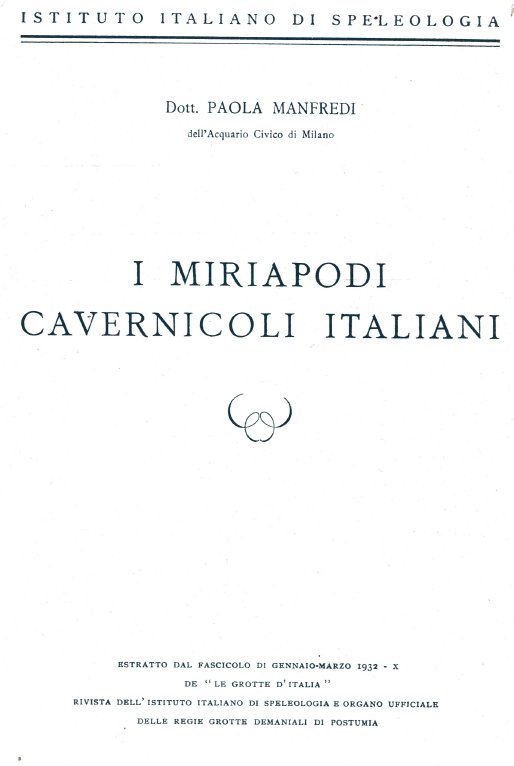 In occasione di alcune ricerche compiute su materiale cavernicolo, in questi ultimi tempi, mi venne fatto di raccogliere molti dati, di sistematica e di bibliografia, intorno ai Miriapodi delle grotte italiane (i). Pensando che qualche notizia in proposito possa interessare gli speleologi — ed anche sperando di invogliarli ad inviarmi materiale di studio — ho compilato per questa Rivista un elenco delle grotte italiane in cui si raccolsero Miriapodi. Come gli speleologi ben sanno, non tutti gli animali che si raccolgono in caverna sono cavernicoli veri; e ciò vale anche per i Miriapodi. Anzi per essi, in modo particolare, dato che molti, vivendo abitualmente sotto i sassi profondamente interrati o nell’humus, prediligono gli ambienti umidi ed oscuri, e quindi con gran facilità si introducono nelle grotte, pur essendo essenzialmente epigei.
In occasione di alcune ricerche compiute su materiale cavernicolo, in questi ultimi tempi, mi venne fatto di raccogliere molti dati, di sistematica e di bibliografia, intorno ai Miriapodi delle grotte italiane (i). Pensando che qualche notizia in proposito possa interessare gli speleologi — ed anche sperando di invogliarli ad inviarmi materiale di studio — ho compilato per questa Rivista un elenco delle grotte italiane in cui si raccolsero Miriapodi. Come gli speleologi ben sanno, non tutti gli animali che si raccolgono in caverna sono cavernicoli veri; e ciò vale anche per i Miriapodi. Anzi per essi, in modo particolare, dato che molti, vivendo abitualmente sotto i sassi profondamente interrati o nell’humus, prediligono gli ambienti umidi ed oscuri, e quindi con gran facilità si introducono nelle grotte, pur essendo essenzialmente epigei.
Estratto dal fascicolo X – le grotte d’Italia
Fenomeni carsici sul monte Cavallo
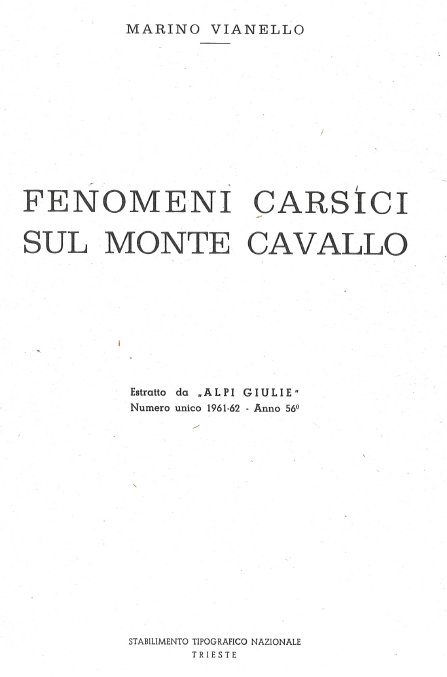 Perduti con la guerra gli altopiani carsici di Tarnova e della Bainsizza, suoi abituali campi d’azione, la Commissione Grotte della Società Alpina delle Giulie dovette indirizzare la sua attività verso altre zone di interesse speleologico. Si pensò alla fascia prealpina friulana, formata da gruppi montuosi dai 1200 ai 2000 metri, intersecati e separati da profonde valli longitudinali e costituita da formazioni calcaree e dolomitiche che vanno dal trias al cretaceo, in parte ricoperte da marne ed arenarie del cenozoico. Dopo alcune esplorazioni nelle zone prealpine più vicine a Trieste, si pensò di estendere l’attività anche al poderoso massiccio Cansiglio-Cavallo ai piedi del quale le sorgenti della Santissima e del Gorgazzo con i loro 5 mc/sec di portata in regime di magra alimentano il fiume Livenza a poche decine di metri slm.
Perduti con la guerra gli altopiani carsici di Tarnova e della Bainsizza, suoi abituali campi d’azione, la Commissione Grotte della Società Alpina delle Giulie dovette indirizzare la sua attività verso altre zone di interesse speleologico. Si pensò alla fascia prealpina friulana, formata da gruppi montuosi dai 1200 ai 2000 metri, intersecati e separati da profonde valli longitudinali e costituita da formazioni calcaree e dolomitiche che vanno dal trias al cretaceo, in parte ricoperte da marne ed arenarie del cenozoico. Dopo alcune esplorazioni nelle zone prealpine più vicine a Trieste, si pensò di estendere l’attività anche al poderoso massiccio Cansiglio-Cavallo ai piedi del quale le sorgenti della Santissima e del Gorgazzo con i loro 5 mc/sec di portata in regime di magra alimentano il fiume Livenza a poche decine di metri slm.
Estratto da Alpi Giulie anno 1956
OSSERVAZIONI MORFOLOGICHE SULLE GRIZE PRESENTI NEL CARSO DI MONFALCONE IN RAPPORTO ALLA LITOLOGIA ED ALLA TETTONICA di GRAZIANO CANCIAN
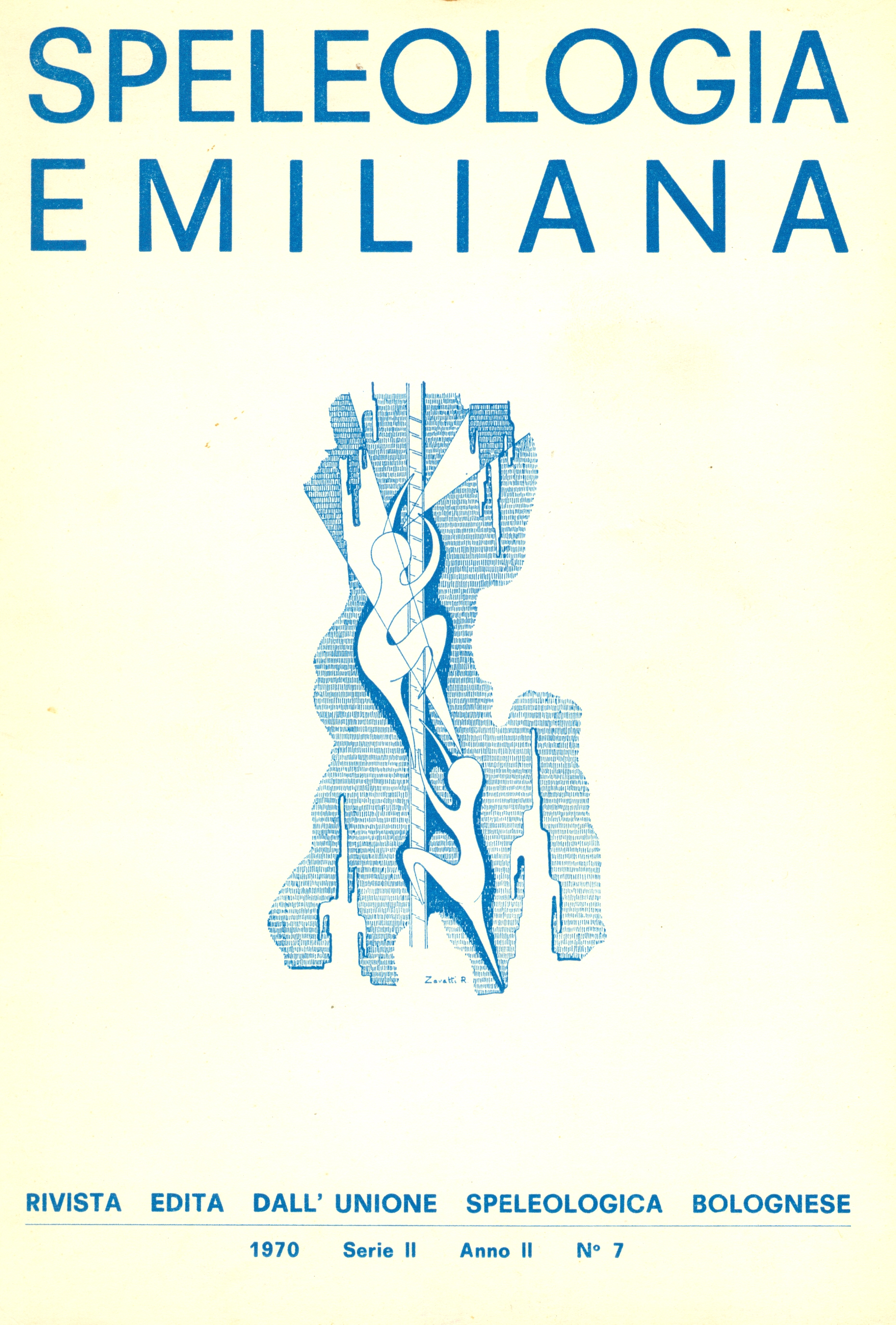 (Gruppo Speleologico Monfalconese)
(Gruppo Speleologico Monfalconese)
Col termine di grize carsiche si usano indicare quei tipici e disordinati accumuli di frammenti calcarei presenti su tutta la superficie del Carso. Questi depositi rappresentano un particolare aspetto della degradazione meteorica cumulativa dei calcari. Nel presente lavoro vengono esaminati i diversi tipi di grize presenti nel Carso di Monfalcone (Gorizia), in rapporto sua litologia ed alla tettonica della zona e vengono distinti quattro tipi diversi di depositi.
Estratto da Speleologia Emiliana pdf
SU DI UN CASO DI RETROVERSIONE
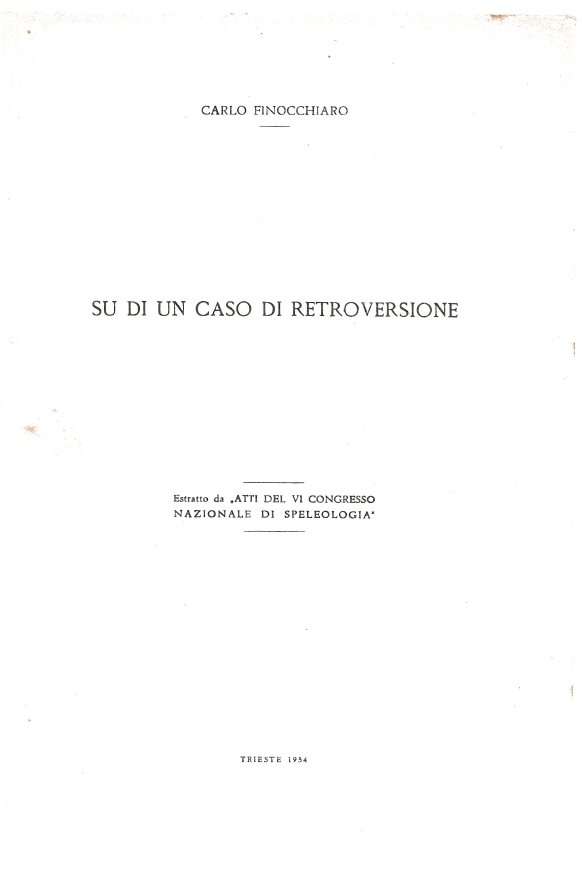 Il termine retroversione è stato introdotto nella speleologia dal Maucci per indicare la direzione di una cavità invertita rispetto a quello del corso d’acqua superficiale. Già il Martel nello schizzo de l’Embut de Saint Lambert ne dà un evidente esempio pur senza soffermarsi sul fenomeno; il Boegan ne diede l’interpretazione grafica, ma il Maucci ne porta numerosi esempi che gli servono quale fondamento per una distinzione morfologica e genetica fra inghiottitoi diretti ed inversi. Mi è sembrato pertanto interessante segnalare un caso di inversione interna, cioè rispetto ad un corso d’acqua già ipogeo, che non può, a mio parere, avere la generi che il Maucci ha generalizzato nella sua ipotesi sulla retroversione del corso.
Il termine retroversione è stato introdotto nella speleologia dal Maucci per indicare la direzione di una cavità invertita rispetto a quello del corso d’acqua superficiale. Già il Martel nello schizzo de l’Embut de Saint Lambert ne dà un evidente esempio pur senza soffermarsi sul fenomeno; il Boegan ne diede l’interpretazione grafica, ma il Maucci ne porta numerosi esempi che gli servono quale fondamento per una distinzione morfologica e genetica fra inghiottitoi diretti ed inversi. Mi è sembrato pertanto interessante segnalare un caso di inversione interna, cioè rispetto ad un corso d’acqua già ipogeo, che non può, a mio parere, avere la generi che il Maucci ha generalizzato nella sua ipotesi sulla retroversione del corso.
Estratto da ATTI DEL VI CONGRESSO NAZIONALE DI SPELEOLOGIA
RICERCHE SULLE GROTTE DELL’ALTIPIANO CARSICO DI CARL MOSER – 1886
Alcune pagine scritte dal Prof. Carlo Moser nell’anno 1886 sulle nuove grotte esplorate sull’altipiano Carsico e della vicina area di Cosina ora in Slovenia.
MOSER Carl, 1886 – Neue Höhlen und Grotten im Küstenland
Diluviale Tierknchen aus der Hohle Tilde (62 VG)
Einst bewohnte Felshohlen des Karste (264 VG
SAULI PIO, 1911 – LE FORMAZIONI CAVERNOSE DEL CARSO
Studi sulla geleologia carsica del 1911 dell’ing. Sauli Pio riferita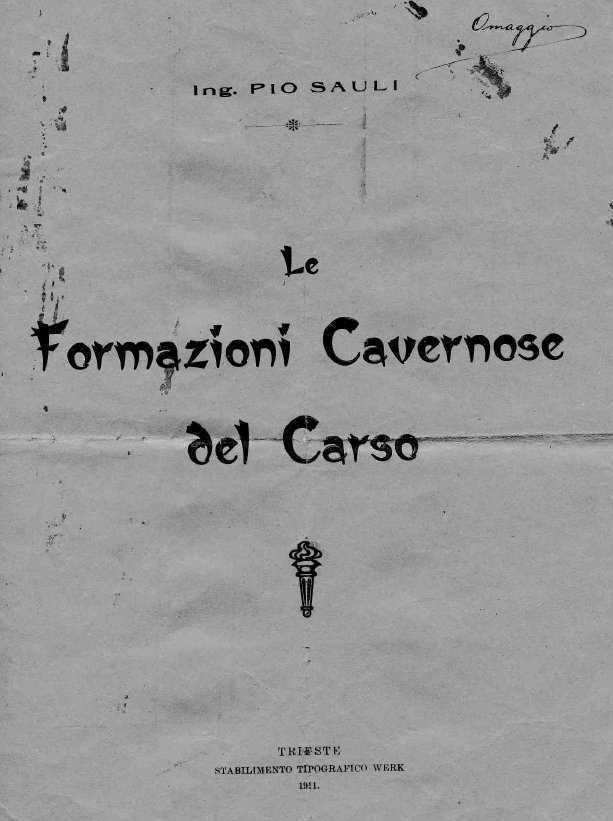 all’area carsica triestina e slovena, dell’altipiano di Auremiano e sulle acque del Recca.
all’area carsica triestina e slovena, dell’altipiano di Auremiano e sulle acque del Recca.
Le formazioni cavernose del Carso
GROTTE ED ABISSI DI PLANINA – DI A.URBAS
Un interessante studio in lingua tedesca 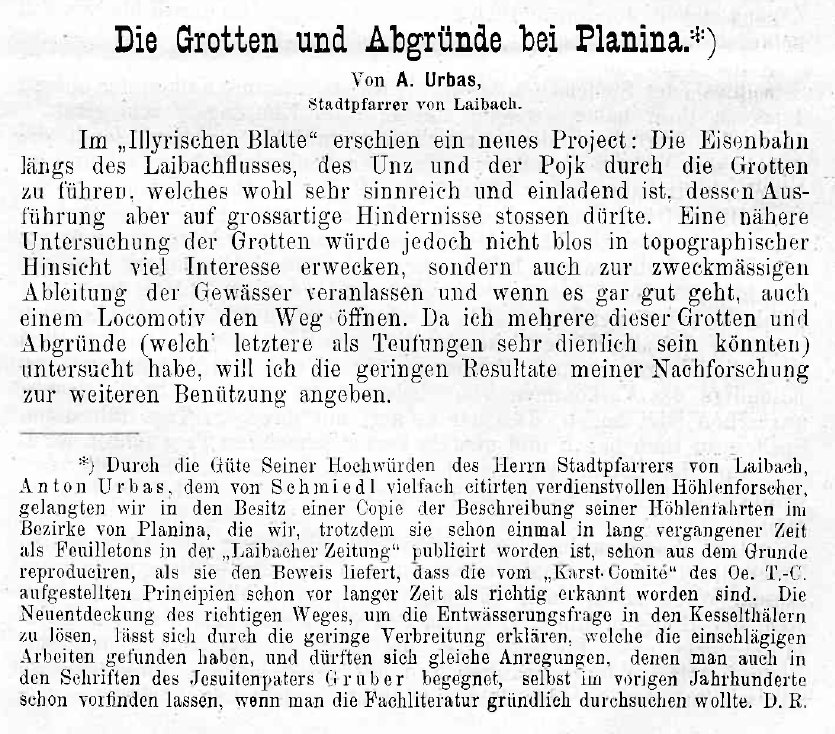 sulla circolazione idrica delle acque nei complessi delle grotte ed abissi di Planina.
sulla circolazione idrica delle acque nei complessi delle grotte ed abissi di Planina.
Die Grotten und Abgründe bei Planina
ALTE UND NEUE PRAHISTORISCHE KARSTHOHLENFUNDE VON NABRESINA
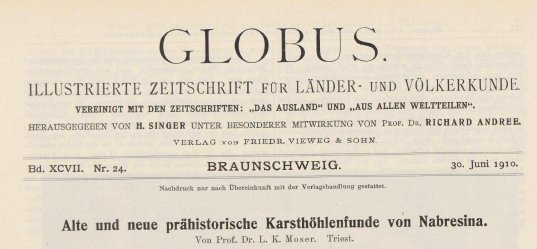 In questo testo il Moser in lingua tedesca descrive le ricerche svolte tra Duino e Sesana in 28 grotte rocciose, di cui 19 sono già state esaminate nella misura in cui sono stati individuati insediamenti preistorici. Qui, solo sette grotte hanno subito uno scavo approfondito per un periodo di 23 anni. Oltre al riposo diluviale degli animali, sono stati osservati insediamenti neolitici in due grotte.
In questo testo il Moser in lingua tedesca descrive le ricerche svolte tra Duino e Sesana in 28 grotte rocciose, di cui 19 sono già state esaminate nella misura in cui sono stati individuati insediamenti preistorici. Qui, solo sette grotte hanno subito uno scavo approfondito per un periodo di 23 anni. Oltre al riposo diluviale degli animali, sono stati osservati insediamenti neolitici in due grotte.
scarica l’articolo in formato pdf
SCHMIDL A., 1850 – DIE HOHLEN DES KARST
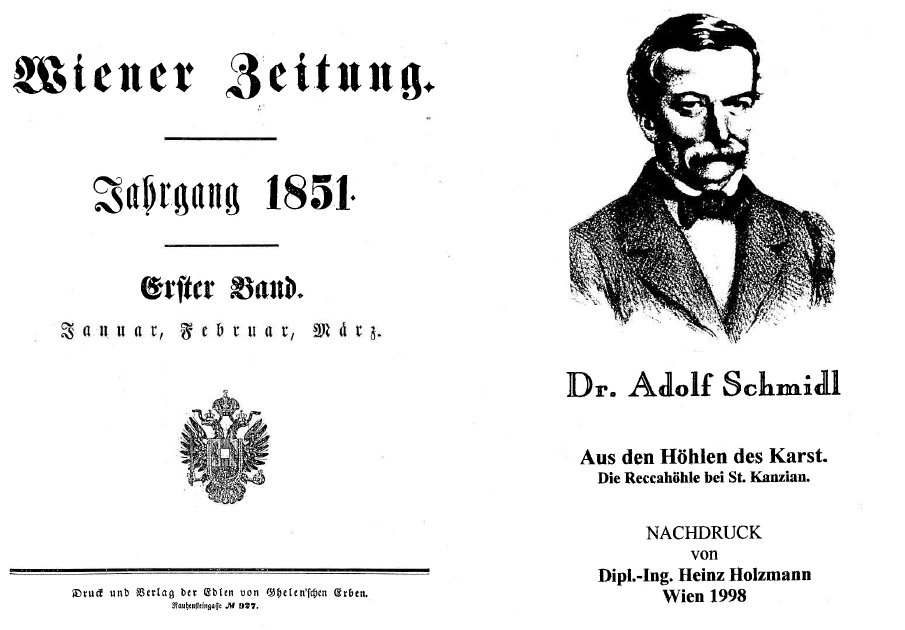 Nel 1851-1852 Adolf Schmidl esplora il bacino Reka-Timavo, studiando il corso sotterraneo S. Canziano (Škocjan)-Duino. Non ottiene buoni risultati, ma gli articoli che egli scrive sul Wiener Zeitung suggeriscono un modello di ricerca integrale che verrà adottato dalle future generazioni di speleologi. Lo Schmidl, con articoli, relazioni, guide, ha il grande merito di rendere il pubblico partecipe dei grandi problemi sorti con l’esplorazione dei fiumi sotterranei, sicchè a ragione può essere considerato uno dei molti padri che vengono attribuiti alla speleologia. Grazie a lui vengono divulgate nozioni prima conosciute solo da pochi esperti e ciò probabilmente influirà qualche decennio più tardi sulla formazione dei primi gruppi grotte.
Nel 1851-1852 Adolf Schmidl esplora il bacino Reka-Timavo, studiando il corso sotterraneo S. Canziano (Škocjan)-Duino. Non ottiene buoni risultati, ma gli articoli che egli scrive sul Wiener Zeitung suggeriscono un modello di ricerca integrale che verrà adottato dalle future generazioni di speleologi. Lo Schmidl, con articoli, relazioni, guide, ha il grande merito di rendere il pubblico partecipe dei grandi problemi sorti con l’esplorazione dei fiumi sotterranei, sicchè a ragione può essere considerato uno dei molti padri che vengono attribuiti alla speleologia. Grazie a lui vengono divulgate nozioni prima conosciute solo da pochi esperti e ciò probabilmente influirà qualche decennio più tardi sulla formazione dei primi gruppi grotte.
Scarica gli articoli storici:
1851 – Aus den Hohlen des Karst (Reccahohle bei St. Kanzian)
1851 – Uber den Unterirdischen lauf der Recca
1852 – Aus den Hohlen des Karst (Lueg, Corgnale, St. Kanzian usw)
1853 – Die Lindner Hohle bei Trebitsch
1853 – Aus den Hohlen des Karst Postumiese
1857 – Aus den Mahrischen Hohlen
1861 – Die Wasserversorgung Triests aus der unterirdischen Recca
SALMOJRAGHI F.1905 – SULLA CONTINUITÀ DEL FIUME TIMAVO – ATTI SOC. IT. SC. NAT.
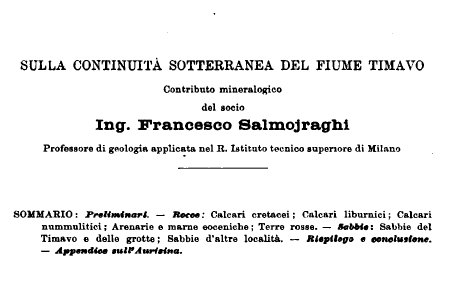 Uno dei fenomeni più grandiosi di idrografia sotterranea è quello che presenta il Timavo nel Carso di Trieste; l’argomento non è nuovo alla letteratura geologica italiana, dappoiché lo descrissero, fra gli altri, Stoppani e Taramelli. Un fiume nasce a pie del monte Catalano, fra il monte Nevoso ed il Quarnero, scorre verso maestro in una valle scolpita per circa 40 chilometri in terreni marno-arenacei, poi per altri 7 chilometri gradatamente si affonda nei calcari e si inabissa nella grotta di S. Canziano; riappare poco dopo per due volte sul fondo di due immani doline, poi definitivamente scompare. È il Timavo soprano, più noto col nome di Recca.
Uno dei fenomeni più grandiosi di idrografia sotterranea è quello che presenta il Timavo nel Carso di Trieste; l’argomento non è nuovo alla letteratura geologica italiana, dappoiché lo descrissero, fra gli altri, Stoppani e Taramelli. Un fiume nasce a pie del monte Catalano, fra il monte Nevoso ed il Quarnero, scorre verso maestro in una valle scolpita per circa 40 chilometri in terreni marno-arenacei, poi per altri 7 chilometri gradatamente si affonda nei calcari e si inabissa nella grotta di S. Canziano; riappare poco dopo per due volte sul fondo di due immani doline, poi definitivamente scompare. È il Timavo soprano, più noto col nome di Recca.
Sulla continuità del fiume timavo
F.Morton dell’Università di Insbruk
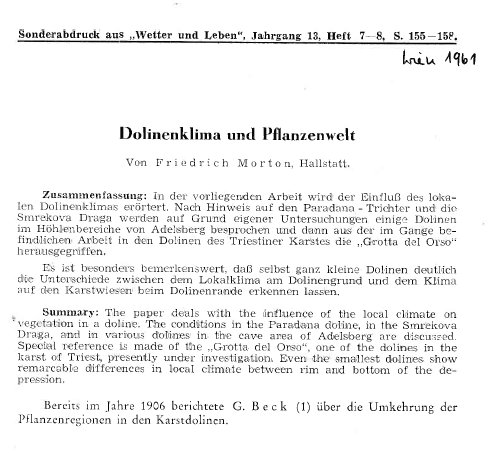 Pubblichiamo alcuni estratti riportati dal F.Morton dell’Università di Insbruk nel 1958 e 1969 di studi botanici, sulla flora e microclima eseguiti in alcune grotte del Ròtelseehòhle (Erlakogel) e nelle doline carsiche anche ai fini agricoli.
Pubblichiamo alcuni estratti riportati dal F.Morton dell’Università di Insbruk nel 1958 e 1969 di studi botanici, sulla flora e microclima eseguiti in alcune grotte del Ròtelseehòhle (Erlakogel) e nelle doline carsiche anche ai fini agricoli.
1958 – Die Pflanzenwelt der Hohlen
1961 -Dolinenklima und Pflanzenwelt
Le risorse idriche della Provincia di Trieste
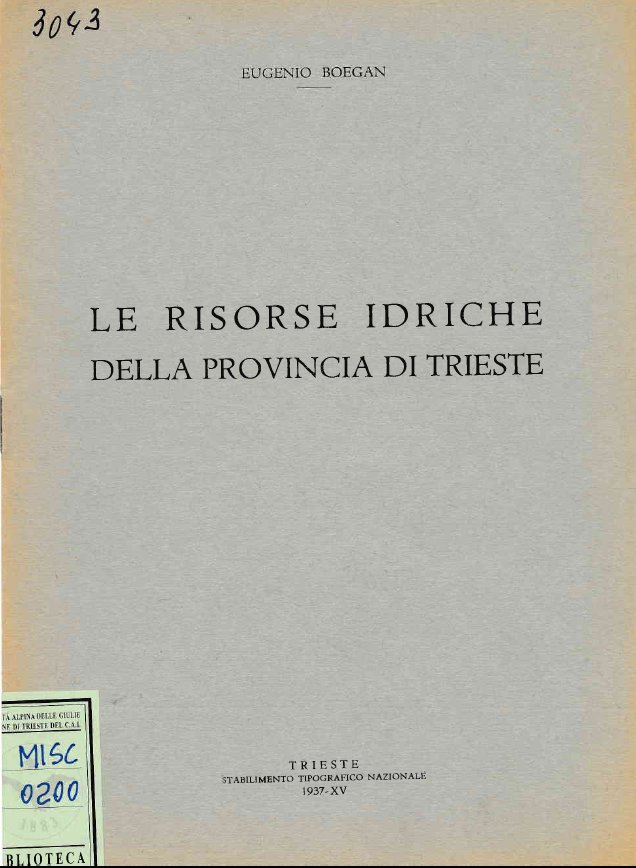 Nella Provincia di Trieste, le risorse idriche non sono eccessive. Il fiume principale è il Timavo che per per 55 chilometri scorre in superficie e per oltre 40 Km è sotterraneo. Le sue sorgenti principali sono quelle della Bistrizza che scaturiscono alle quote 420-430 m. sopra il livello marino. Portate minime di tali sorgenti vennero constatate il 9 settembre 1911 con 10.068 mc nelle 24 ore (mc/sec. 0.117) e il 21 ottobre 1921 con 10.560 mc. Una massima piena fu rilevata il 2 dicembre 1870 con 355.300 mc nelle 24 ore (mc./sec. 4.1).
Nella Provincia di Trieste, le risorse idriche non sono eccessive. Il fiume principale è il Timavo che per per 55 chilometri scorre in superficie e per oltre 40 Km è sotterraneo. Le sue sorgenti principali sono quelle della Bistrizza che scaturiscono alle quote 420-430 m. sopra il livello marino. Portate minime di tali sorgenti vennero constatate il 9 settembre 1911 con 10.068 mc nelle 24 ore (mc/sec. 0.117) e il 21 ottobre 1921 con 10.560 mc. Una massima piena fu rilevata il 2 dicembre 1870 con 355.300 mc nelle 24 ore (mc./sec. 4.1).
Rund um den Unninger, 1927
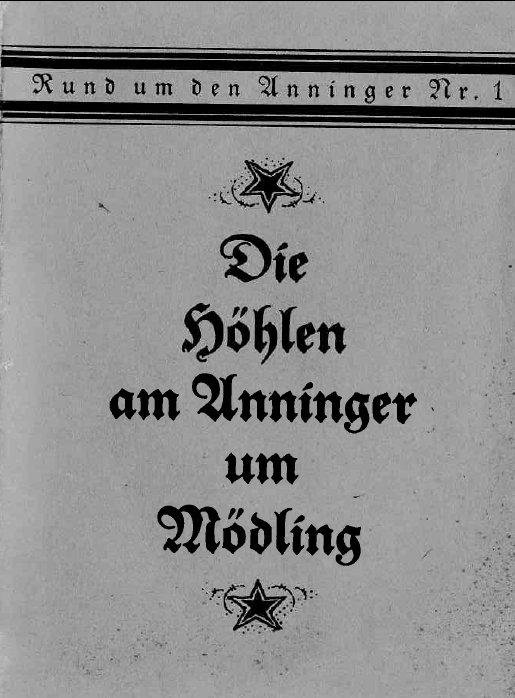 Uno studio del Bachmann sulla flora e fauna delle grotte e delle zone umide prossime alle grotte.
Uno studio del Bachmann sulla flora e fauna delle grotte e delle zone umide prossime alle grotte.
Scarica il volume in lingiua tedesca
Weis’sche Buchdrukerei, 1855
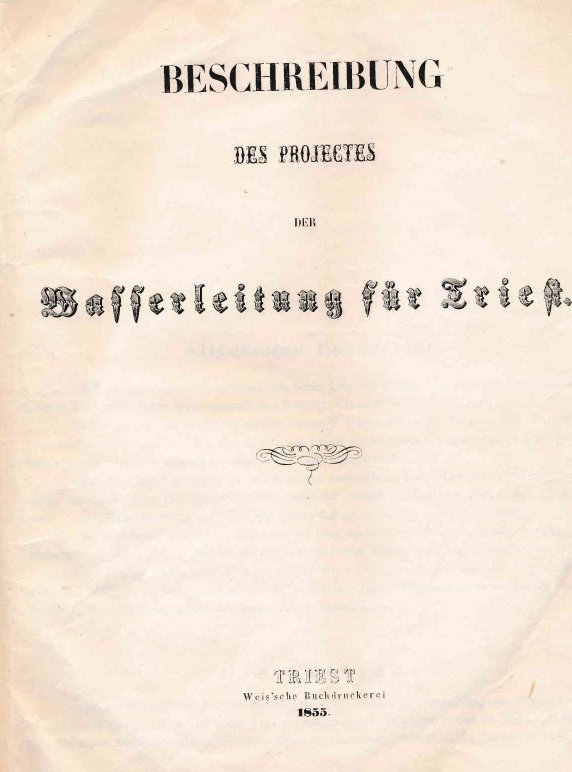 Studi del Karl Junker per l’approvigionamento idrico della citta di Trieste
Studi del Karl Junker per l’approvigionamento idrico della citta di Trieste
Scarica il volume in lingua tedesca
Carlo Oberst, 1899
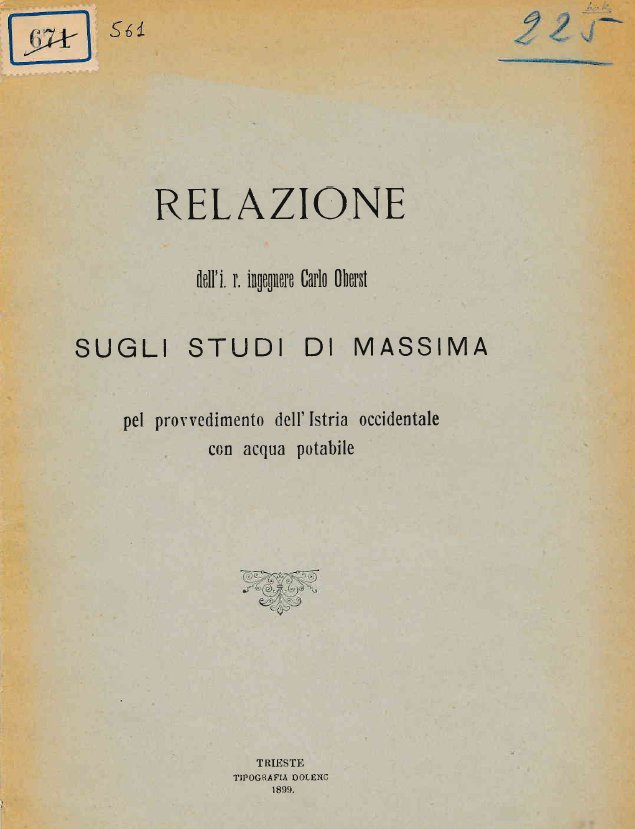 Secondo le condizioni geologiche tutto speciali dell’ Istria
Secondo le condizioni geologiche tutto speciali dell’ Istria
una gran parte di questa provincia è affatto priva di corsi d’acqua e
di sorgenti, sicchè il modo di approvigionarla attualmente di acqua
potabile si riduce alla costruzione di cisterne e stagni, insufflcicnti per
lo più nei mesi estivi di provvedere ai bisogni più urgenti della popolazione
del bestiame.
PENCK A.1904
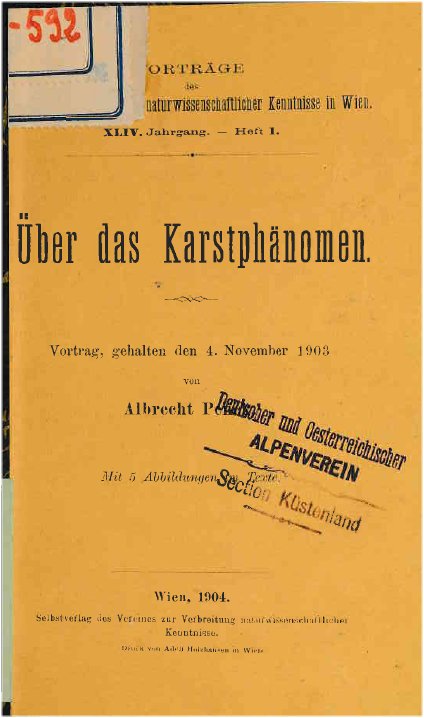 Wiener Forschers, Dr. Alfred Grund; grazie ad entrambi gli studi è ora possibile vedere chiaramente i fenomeni carsici dopo alcune serie di sviluppo. Nel fare ciò, tuttavia, ci occuperemo in questo libro solo delle caratteristiche della superficie, in particolare dei paesi carsici dell’Adriatico, ma non del loro carattere paesaggistico. Questo deve essere sottolineato perché, secondo la lingua usata, in molti casi solo la terra è considerata carsificata, che è povera di vegetazione, mentre il terreno carsico può anche essere collegato con una fitta copertura forestale, come si può vedere nel nord di Adelsberg: lo splendido Waldèr si trova lì su un calcare che porta tutte le caratteristiche del design superficiale del Carso meridionale.
Wiener Forschers, Dr. Alfred Grund; grazie ad entrambi gli studi è ora possibile vedere chiaramente i fenomeni carsici dopo alcune serie di sviluppo. Nel fare ciò, tuttavia, ci occuperemo in questo libro solo delle caratteristiche della superficie, in particolare dei paesi carsici dell’Adriatico, ma non del loro carattere paesaggistico. Questo deve essere sottolineato perché, secondo la lingua usata, in molti casi solo la terra è considerata carsificata, che è povera di vegetazione, mentre il terreno carsico può anche essere collegato con una fitta copertura forestale, come si può vedere nel nord di Adelsberg: lo splendido Waldèr si trova lì su un calcare che porta tutte le caratteristiche del design superficiale del Carso meridionale.
RICHETTI G. – 1887
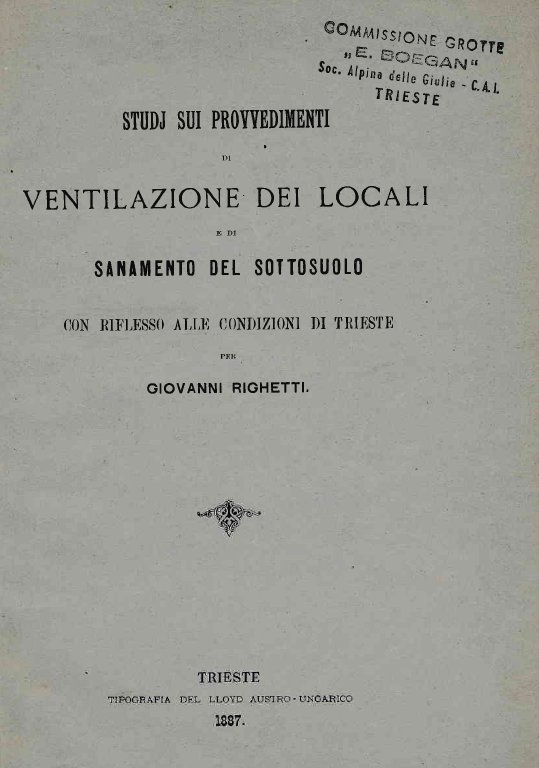 Il bisogno di ripararsi quanto più possibile dalle influenze e dalle alterazioni atmosferiche, spinse 1′ uomo alla costruzione ed al successivo perfezionamento delle sue abitazioni. Affinchè queste corrispondano, devono contenere degli ambienti rinchiusi da pareti, soffitti e pavimenti da un lato, provveduti da porte e di finestre dall’altro. Però se da un canto tali costruzioni difendono 1’uomo dalle maggiori variazioni atmosferiche, quali sarebbero: venti, pioggie, uragani, nevi, ecc, non giungono a preservare i singoli ambienti di esse, dalle correnti e dalle infiltrazioni dell’ aria, e dai rapidi cambiamenti di temperatura.
Il bisogno di ripararsi quanto più possibile dalle influenze e dalle alterazioni atmosferiche, spinse 1′ uomo alla costruzione ed al successivo perfezionamento delle sue abitazioni. Affinchè queste corrispondano, devono contenere degli ambienti rinchiusi da pareti, soffitti e pavimenti da un lato, provveduti da porte e di finestre dall’altro. Però se da un canto tali costruzioni difendono 1’uomo dalle maggiori variazioni atmosferiche, quali sarebbero: venti, pioggie, uragani, nevi, ecc, non giungono a preservare i singoli ambienti di esse, dalle correnti e dalle infiltrazioni dell’ aria, e dai rapidi cambiamenti di temperatura.
Studi sui provvedimenti di ventilazione dei locali e risanamento del sottosuolo
RIGHETTI G. e VICENTINI – 1871
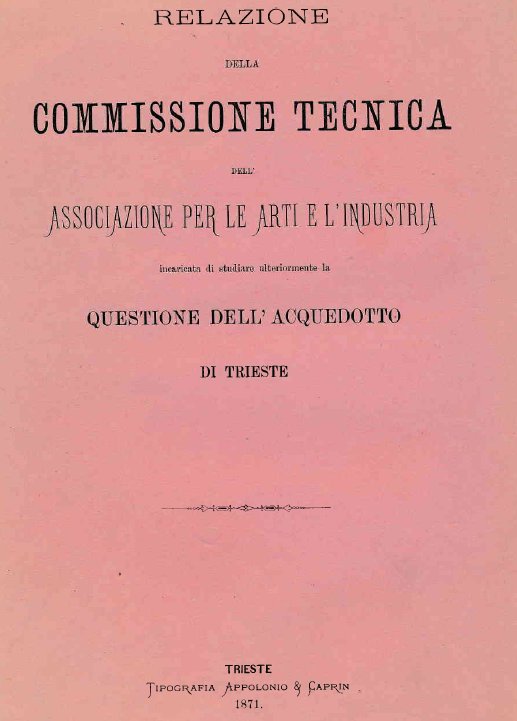 Motivo ad occuparsi nuovamente della questione dell’ acquedotto triestino in progetto, diede in parte la Risposta dell’ ingegnere sig. Burkli al Voto emesso dalla scrivente Commissione tecnica sulla sua Relazione. Prima di entrare nel merito della questione, la sottoscritta si permette di far precedere la citazione di qualche fatto e ciò coll’intendimento di rendere consapevole il lettore del come la cessata Delegazione municipale credette opportuno di agire in un oggetto di tanta rilevanza economico-finanziaria, e nello stesso tempo promunirlo contro certe insinuazioni indecorose che i fautori del Risano in mancanza di solidi argomenti tentano di propagare nel pubblico.
Motivo ad occuparsi nuovamente della questione dell’ acquedotto triestino in progetto, diede in parte la Risposta dell’ ingegnere sig. Burkli al Voto emesso dalla scrivente Commissione tecnica sulla sua Relazione. Prima di entrare nel merito della questione, la sottoscritta si permette di far precedere la citazione di qualche fatto e ciò coll’intendimento di rendere consapevole il lettore del come la cessata Delegazione municipale credette opportuno di agire in un oggetto di tanta rilevanza economico-finanziaria, e nello stesso tempo promunirlo contro certe insinuazioni indecorose che i fautori del Risano in mancanza di solidi argomenti tentano di propagare nel pubblico.
Relazione della Commissione tecnica incaricata di studiare la questione dell’acquedotto di Trieste
Città di Gorizia riguardo il provvedimento dell’ACQUA POTABILE
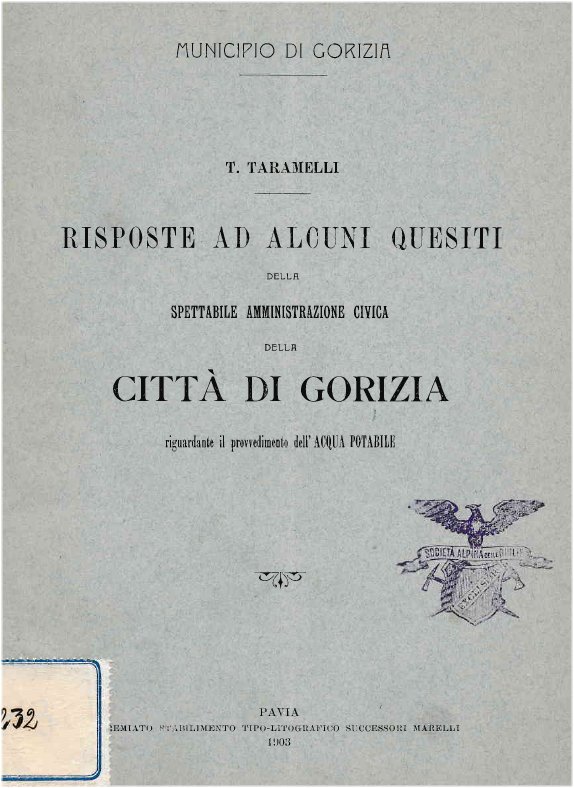 Lo scrivente nel dicembre dello scorso anno veniva onorato dal Municipio di Gorizia dei seguenti quesiti, motivati dall’esito sino allora meno felice di alcuni lavori di ricerca, eseguiti presso la fonte della Merzlek, in prossimità di Salcano, e dall’essersi ventilato altresì il progetto di innalzare l’acqua del sottosuolo, in una località poco discosta, verso sud, dalla città elaborato dal signor ingegnere Smreker. I quesiti sono i seguenti: Visti i quattro rapporti dell’Ispettore Tschebull ed i suoi disegni, si domanda se con lo scavo di due gallerie orizzontali si possa ottenere l’intera acqua della Merzlek (o almeno la quantità di 70 litri al minuto secondo necessari per la città di Gorizia) ad un livello tale da poter escludere l’innalzamento meccanico della medesima.
Lo scrivente nel dicembre dello scorso anno veniva onorato dal Municipio di Gorizia dei seguenti quesiti, motivati dall’esito sino allora meno felice di alcuni lavori di ricerca, eseguiti presso la fonte della Merzlek, in prossimità di Salcano, e dall’essersi ventilato altresì il progetto di innalzare l’acqua del sottosuolo, in una località poco discosta, verso sud, dalla città elaborato dal signor ingegnere Smreker. I quesiti sono i seguenti: Visti i quattro rapporti dell’Ispettore Tschebull ed i suoi disegni, si domanda se con lo scavo di due gallerie orizzontali si possa ottenere l’intera acqua della Merzlek (o almeno la quantità di 70 litri al minuto secondo necessari per la città di Gorizia) ad un livello tale da poter escludere l’innalzamento meccanico della medesima.
Risposte ad alcuni quesiti riguardo il provvedimento dell’ACQUA POTABILE per Gorizia
PRINCIPALI FIUMI SOTERRANEI NELL’ADRIATICO ORIENTALE
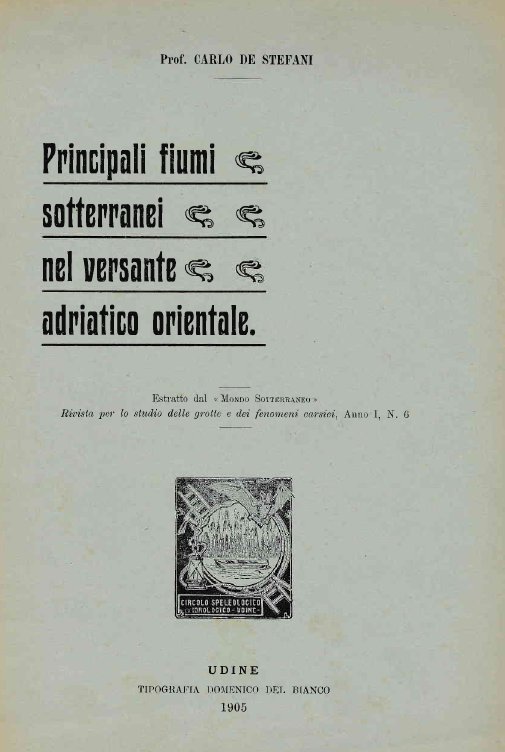 Da un piccolo lavoro che sono venuto preparando sulla genesi dell’Adriatico e dei suoi versanti, ritraggo quanto riguarda sommariamente l’idrografia sotterranea del versante balcanico. Quantunque abbia visitato almeno la foce di molta parte dei fiumi sotterranei dei quali parlo, pur la mia nota è di semplice sommaria compilazione. Servirà nondimeno a dare un riassunto di fatti Importantissimi e svariati che in quel versante si osservano. Contrada classica sopra ogni altra per la circolazione sotterranea delle acque è la penisola balcanica, principalmente dal Carso al Montenegro. Essendo costituita quasi generalmente da calcari, questi sono tutti bucati internamente per l’erosione chimica prodotta dalle acque e indipendentemente da ogni azione meccanica prodotta da ripiegamento e da turbamento degli strati. L’intensità dell’erosione sotterranea è rispondente all’antichità, del tempo da che quella regione è emersa, perciò soggetta all’azione delle acque atmosferiche.
Da un piccolo lavoro che sono venuto preparando sulla genesi dell’Adriatico e dei suoi versanti, ritraggo quanto riguarda sommariamente l’idrografia sotterranea del versante balcanico. Quantunque abbia visitato almeno la foce di molta parte dei fiumi sotterranei dei quali parlo, pur la mia nota è di semplice sommaria compilazione. Servirà nondimeno a dare un riassunto di fatti Importantissimi e svariati che in quel versante si osservano. Contrada classica sopra ogni altra per la circolazione sotterranea delle acque è la penisola balcanica, principalmente dal Carso al Montenegro. Essendo costituita quasi generalmente da calcari, questi sono tutti bucati internamente per l’erosione chimica prodotta dalle acque e indipendentemente da ogni azione meccanica prodotta da ripiegamento e da turbamento degli strati. L’intensità dell’erosione sotterranea è rispondente all’antichità, del tempo da che quella regione è emersa, perciò soggetta all’azione delle acque atmosferiche.
Principali fiumi sotterranei del versante adriatico orientale
Prima segnalazione della presenza del Giurassico superiore e del Cretacico superiore nel gruppo del Monte Canin (Alpi Giulie)
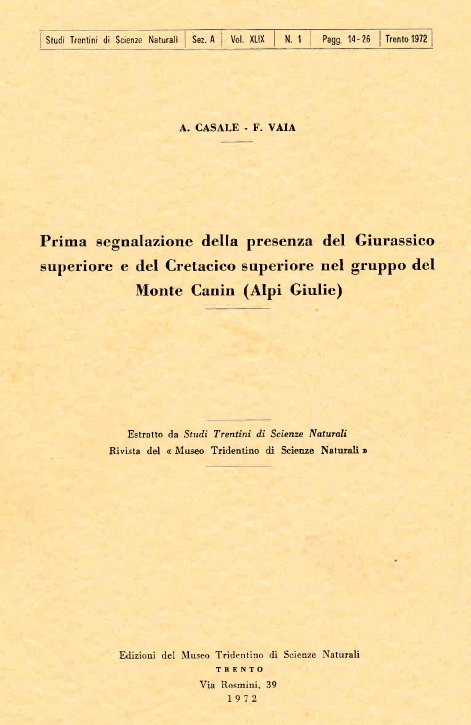 Nel corso degli anni 1969-1970 sono stati eseguiti a più riprese rilievi e campionature nel gruppo del M. Canin in territorio italiano per riconoscerne Tassello tettonico e la successione stratigrafica. Si erano occupati della stessa zona dal punto di vista geologico A. Desio (1925) e R. Selli (1963), G.B. De Gasperi (1915) dal punto di vista geografico e morfologico. Secondo questi Autori la successione nella zona termina al tetto con strati del Giurassico inferiore di certa determinazione cui si sovrappongono altri supposti del Giurassico medio con determinazione incerta.
Nel corso degli anni 1969-1970 sono stati eseguiti a più riprese rilievi e campionature nel gruppo del M. Canin in territorio italiano per riconoscerne Tassello tettonico e la successione stratigrafica. Si erano occupati della stessa zona dal punto di vista geologico A. Desio (1925) e R. Selli (1963), G.B. De Gasperi (1915) dal punto di vista geografico e morfologico. Secondo questi Autori la successione nella zona termina al tetto con strati del Giurassico inferiore di certa determinazione cui si sovrappongono altri supposti del Giurassico medio con determinazione incerta.
Il Paleotimavo e l’antica idrografia subaerea del Carso triestino
Molte ricerche sono state fatte nei riguardi del corso sotterraneo del Timavo, e sembra ormai acquisito che la maggior parte delle acque, di questo fiume segue la via segnata dall’Abisso dei Serpenti, Grotta Sottocorona, Grotta dì Corgnale, Grotta delle Torri, Voragine dei Corvi, Grotta di Trebiciano, Abisso di Monrupino, Grotta Gigante, Abisso Martel, Grotta di Gabrovizza, Grotta Noè, Grotta della Stazione di Aurisina, San Giovanni di Tuba. È cosa provata sperimentalmente poi che nell’Abisso dei Serpenti e nella Grotta di Trebiciano si ritrovano effettivamente le acque del Timavo, come pure è provato sperimentalmente che esse sgorgano a S. Giovanni di Tuba. Molto più divise sono le opinioni invece su quello che doveva essere il corso subaereo del Timavo prima che le sue acque venissero per intero assorbite in corrispondenza di S. Canziano; la questione è poi anche meno approfondita, quantunque essa sembri degna di molta attenzione.
Il Paleotimavo e l’antica idrografia subaerea del Carso triestino
Ogservazioni geomorfologiche sulle doline del Carso Triestino
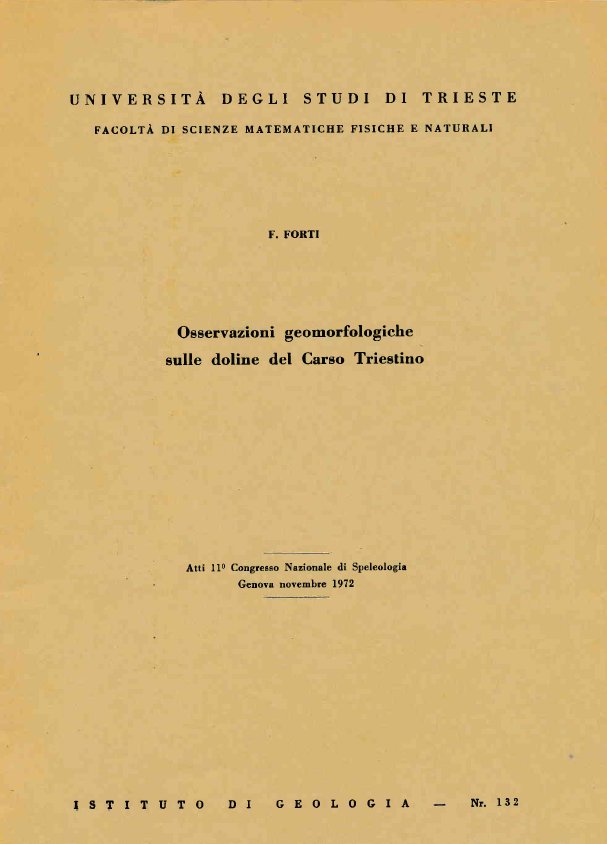 Vengono presentati i risultati preliminari di una ricerca geomorfologica sulle doline del Carso Triestino, prendendo per base recenti ricerche compiute da Aubert D. (1966, 1969) sul Carso Giurassico (Svizzera). Viene presentata l’attività tipo di una dolina nelle carbonatiti compatte, suddivisa secondo azioni dissolutive di approfondimento e di allargamento della dolina ed azioni di trasporto per riempimento ed evacuazione. Vengono presentate infine le morfologie carsiche presenti nella dolina, ivi comprese le piccole forme di corrosione.
Vengono presentati i risultati preliminari di una ricerca geomorfologica sulle doline del Carso Triestino, prendendo per base recenti ricerche compiute da Aubert D. (1966, 1969) sul Carso Giurassico (Svizzera). Viene presentata l’attività tipo di una dolina nelle carbonatiti compatte, suddivisa secondo azioni dissolutive di approfondimento e di allargamento della dolina ed azioni di trasporto per riempimento ed evacuazione. Vengono presentate infine le morfologie carsiche presenti nella dolina, ivi comprese le piccole forme di corrosione.
Osservazioni geomorfologiche sulle doline del Carso Triestino
ANTONIO MARUSSI – PALEOTIMAVO E L’ANTICA IDROGRAFIA SUBAEREA
DEL CARSO TRIESTINO
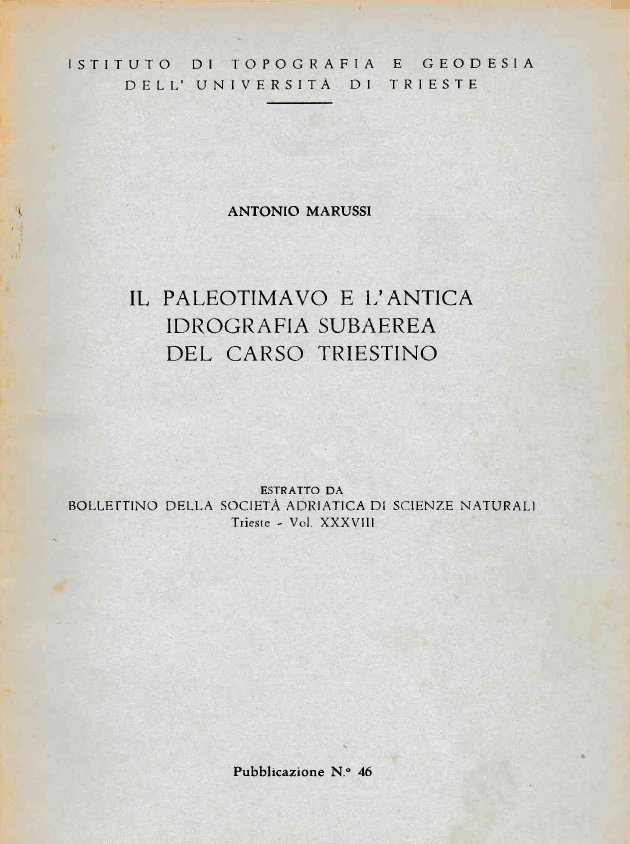 Molte ricerche sono state fatte nei riguardi del corse sotterraneo del Timavo, e sembra ormai acquisito che la maggior parte delle acque di questo fiume segue la via segnata dall’Abisso dei Serpenti, Grotta Sottocorona, Grotta dì Corgnale, Grotta delle Torri, Voragine dei Corvi, Grotta di Trebiciano, Abisso di Monrupino, Grotta Gigante, Abisso Marte], Grotta di Gabrovizza, Grotta Noè, Grotta della Stazione di Aurisina, San Giovanni di Tuba. È cosa provata sperimentalmente poi che nell’Abisso dei Serpenti e nella Grotta di Trebiciano si ritrovano effettivamente le acque del Timavo, come pure è provato sperimentalmente che esse sgorgano a S. Giovanni di Tuba. Molto più divise sono le opinioni invece su quello che doveva essere il corso subaereo del Timavo prima che le sue acque venissero per intero assorbite in corrispondenza di S. Canziano; la questione è poi anche meno approfondita, quantunque essa sembri degna di molta attenzione.
Molte ricerche sono state fatte nei riguardi del corse sotterraneo del Timavo, e sembra ormai acquisito che la maggior parte delle acque di questo fiume segue la via segnata dall’Abisso dei Serpenti, Grotta Sottocorona, Grotta dì Corgnale, Grotta delle Torri, Voragine dei Corvi, Grotta di Trebiciano, Abisso di Monrupino, Grotta Gigante, Abisso Marte], Grotta di Gabrovizza, Grotta Noè, Grotta della Stazione di Aurisina, San Giovanni di Tuba. È cosa provata sperimentalmente poi che nell’Abisso dei Serpenti e nella Grotta di Trebiciano si ritrovano effettivamente le acque del Timavo, come pure è provato sperimentalmente che esse sgorgano a S. Giovanni di Tuba. Molto più divise sono le opinioni invece su quello che doveva essere il corso subaereo del Timavo prima che le sue acque venissero per intero assorbite in corrispondenza di S. Canziano; la questione è poi anche meno approfondita, quantunque essa sembri degna di molta attenzione.
Ipotesi sullo sviluppo del carsismo (Osservazioni sul Carso Triestino e sull’Istria)
Die Tropfsteinhohle von Slivno bei Nabresina (Triester Karst) Von G.Andreas Perko
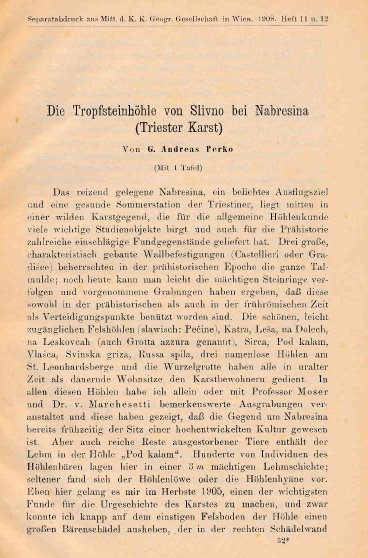 Nabresina, una destinazione popolare per escursioni e una salutare sosta estiva per la gente di Trieste, si trova nel mezzo del selvaggio Karstgegend, che contiene molti importanti oggetti di studio per la scienza generale e ha anche fornito numerosi reperti rilevanti per la preistoria. Nella preistoria, tre grandi fortificazioni a muro (Castellieri o Gradisce) dominavano l’intera valle; precedenti scavi hanno dimostrato che questi erano usati sia nella preistoria che nei primi romani come punti di difesa. I pendii rocciosi e le grotte dell’area sono state tutte residenze permanenti per gli abitanti del Carso nei tempi antichi. In tutte queste grotte ho il Moser e il Marchesetti intrapresero scavi di grande valore e questi hanno dimostrato che l’area intorno a Nabresina fu presto sede di una cultura altamente sviluppata. L’argilla nella grotta “Pod kalam” contiene anche abbondanti resti di animali estinti: centinaia di individui della betulla cava giacevano qui in uno strato di argilla spesso 3 m.
Nabresina, una destinazione popolare per escursioni e una salutare sosta estiva per la gente di Trieste, si trova nel mezzo del selvaggio Karstgegend, che contiene molti importanti oggetti di studio per la scienza generale e ha anche fornito numerosi reperti rilevanti per la preistoria. Nella preistoria, tre grandi fortificazioni a muro (Castellieri o Gradisce) dominavano l’intera valle; precedenti scavi hanno dimostrato che questi erano usati sia nella preistoria che nei primi romani come punti di difesa. I pendii rocciosi e le grotte dell’area sono state tutte residenze permanenti per gli abitanti del Carso nei tempi antichi. In tutte queste grotte ho il Moser e il Marchesetti intrapresero scavi di grande valore e questi hanno dimostrato che l’area intorno a Nabresina fu presto sede di una cultura altamente sviluppata. L’argilla nella grotta “Pod kalam” contiene anche abbondanti resti di animali estinti: centinaia di individui della betulla cava giacevano qui in uno strato di argilla spesso 3 m.
Die Tropfsteinhohle von Slivno bei Nabresina (Triester Karst)
Zur osterreichischen Karstholenforschung – PERKO G. And., 1910
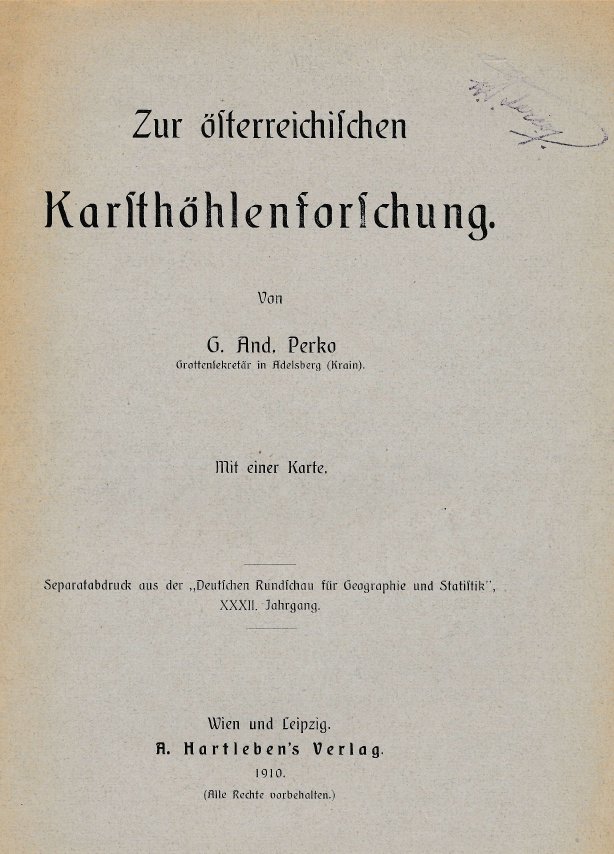 Gli studi del PerKo sul carso con una crta geografica d’epoca con indicate le grotte oggetto del volume.
Gli studi del PerKo sul carso con una crta geografica d’epoca con indicate le grotte oggetto del volume.
Zur osterreichischen Karstholenforschung
Il provvedimento idrico della città di Trieste – IELLERSITZ A.
 Su questo assillante problema, che ormai si trascina da più di un secolo, attendendo finora purtroppo inutilmente la sua definitiva soluzione, problema che costituisce il cardine fondamentale per l’attuazione dei principali quesiti, che stanno in nesso al tanto invocato problema della bonifica e dell’assanamento generale del nostro sottosuolo cloacale, furono fatte a suo tempo relazioni, studi e proposte, discusse fino a sazietà, furono sentiti i più disparati pareri di autorità tecniche e sanitarie, con lo spreco di somme cospicue, per piani progetti e pareri elaborati nei minimi dettagli, che purtroppo lasciano oggi ancora il tempo che trova, rimanendo insoluta la scottante questione.
Su questo assillante problema, che ormai si trascina da più di un secolo, attendendo finora purtroppo inutilmente la sua definitiva soluzione, problema che costituisce il cardine fondamentale per l’attuazione dei principali quesiti, che stanno in nesso al tanto invocato problema della bonifica e dell’assanamento generale del nostro sottosuolo cloacale, furono fatte a suo tempo relazioni, studi e proposte, discusse fino a sazietà, furono sentiti i più disparati pareri di autorità tecniche e sanitarie, con lo spreco di somme cospicue, per piani progetti e pareri elaborati nei minimi dettagli, che purtroppo lasciano oggi ancora il tempo che trova, rimanendo insoluta la scottante questione.
Il provvedimento idrico della città di Trieste
Il Timavo Virgiliano e gli abissi misteriosi di S. Canziano presso Trieste – Sergio Gradenigo 1925
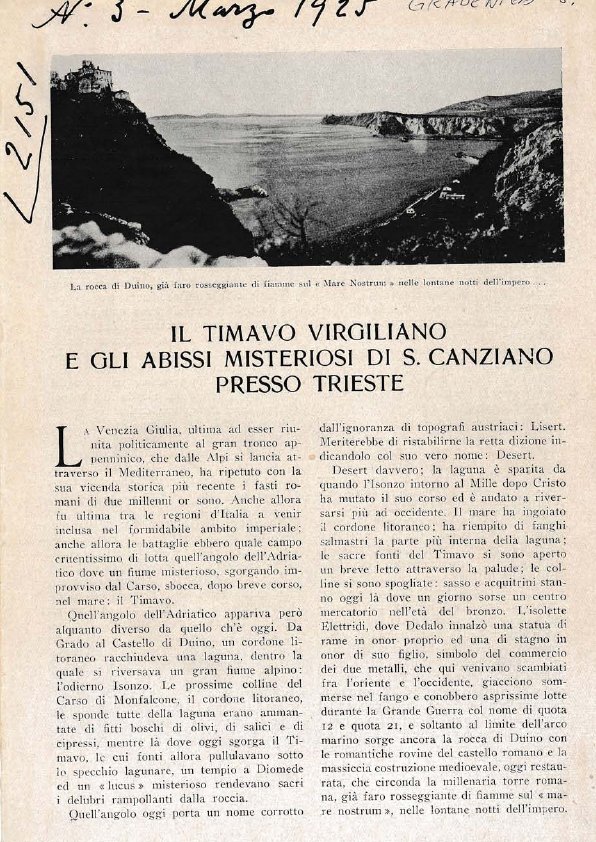 La Venezia Giulia, ultima ad esser riunita politicamente al gran tronco appenninico, che dalle Alpi sì lancia attraverso il Mediterraneo, ha ripetuto con la sua vicenda storica il più recente dei fasti romani di due millenni or sono. Anche allora qui ultima tra le regioni d’Italia a venir inclusa nel formidabile ambito imperiale; anche allora le battaglie ebbero quale campo cruentissimo di lotta quell’angolo dell’Adriatico dove un fiume misterioso, sgorgando improvviso dal Carso, sbocca, dopo breve còrso, nel mare: il Timavo. Quell’angolo dell’Adriatico appariva però alquanto diverso da quello ch’è oggi. Da Grado al Castello di Duino, un cordone litoraneo racchiudeva una laguna, dentro la quale si riversava un gran fìume alpino: l’odierno Isonzo. Le prossime colline del Carso di Monfalcone, il cordone litoraneo, le sponde tutte della laguna erano ammantate di fitti boschi di olivi, di salici e di cipressi, mentre là dove oggi sgorga il Timavo, le cui fonti allora pullulavano sotto lo specchio lagunare, un tempio a Diomede ed un « Incus » misterioso rendevano sacri i delubri rampollanti dalla roccia. Quell’angolo oggi porta un nome corrotto dall’ignoranza di topografi austriaci: Lisert, Meriterebbe di ristabilirne là retta dizione indicandolo col suo vero nome: Desert. Desert davvero; la laguna è sparita da quando l’Isonzo intorno al Mille dopo Cristo ha mutato il suo corso ed è andato a riversarsi più ad occidente. II mare ha ingoiato il cordone litoraneo; ha riempito di fanghi salmastri la parte più interna della laguna; le sacre fonti del Timavo si sono aperte un breve letto attraverso la palude: le colline si sono spogliate; sasso e acquitrini stanno oggi là dove un giorno sorse un centro mercatorio nell’età del bronzo. L’isolette Elettridi, dove Dedalo innalzò una statua di rame in onor proprio ed una di stagno in onor di suo figlio, simbolo del commercio dei due metalli, che qui venivano scambiati fra l’oriente e l’occidente, giacciono sommerse nel fango e conobbero asprissime lotte durante la Grande Guerra col nome di quota 12 e quota 21, e soltanto al limite dell’arco marino sorge ancora la rocca di Duino con le romantiche rovine del castello romano e la massiccia costruzione medioevale, oggi restaurata, che circonda la millenaria torre romana, già faro rosseggiale di fiamme sul mare nostrum, nelle lontane notti dell’impero.
La Venezia Giulia, ultima ad esser riunita politicamente al gran tronco appenninico, che dalle Alpi sì lancia attraverso il Mediterraneo, ha ripetuto con la sua vicenda storica il più recente dei fasti romani di due millenni or sono. Anche allora qui ultima tra le regioni d’Italia a venir inclusa nel formidabile ambito imperiale; anche allora le battaglie ebbero quale campo cruentissimo di lotta quell’angolo dell’Adriatico dove un fiume misterioso, sgorgando improvviso dal Carso, sbocca, dopo breve còrso, nel mare: il Timavo. Quell’angolo dell’Adriatico appariva però alquanto diverso da quello ch’è oggi. Da Grado al Castello di Duino, un cordone litoraneo racchiudeva una laguna, dentro la quale si riversava un gran fìume alpino: l’odierno Isonzo. Le prossime colline del Carso di Monfalcone, il cordone litoraneo, le sponde tutte della laguna erano ammantate di fitti boschi di olivi, di salici e di cipressi, mentre là dove oggi sgorga il Timavo, le cui fonti allora pullulavano sotto lo specchio lagunare, un tempio a Diomede ed un « Incus » misterioso rendevano sacri i delubri rampollanti dalla roccia. Quell’angolo oggi porta un nome corrotto dall’ignoranza di topografi austriaci: Lisert, Meriterebbe di ristabilirne là retta dizione indicandolo col suo vero nome: Desert. Desert davvero; la laguna è sparita da quando l’Isonzo intorno al Mille dopo Cristo ha mutato il suo corso ed è andato a riversarsi più ad occidente. II mare ha ingoiato il cordone litoraneo; ha riempito di fanghi salmastri la parte più interna della laguna; le sacre fonti del Timavo si sono aperte un breve letto attraverso la palude: le colline si sono spogliate; sasso e acquitrini stanno oggi là dove un giorno sorse un centro mercatorio nell’età del bronzo. L’isolette Elettridi, dove Dedalo innalzò una statua di rame in onor proprio ed una di stagno in onor di suo figlio, simbolo del commercio dei due metalli, che qui venivano scambiati fra l’oriente e l’occidente, giacciono sommerse nel fango e conobbero asprissime lotte durante la Grande Guerra col nome di quota 12 e quota 21, e soltanto al limite dell’arco marino sorge ancora la rocca di Duino con le romantiche rovine del castello romano e la massiccia costruzione medioevale, oggi restaurata, che circonda la millenaria torre romana, già faro rosseggiale di fiamme sul mare nostrum, nelle lontane notti dell’impero.
Il Timavo virgiliano e gli abissi misteriosi di S. Canziano presso Trieste
